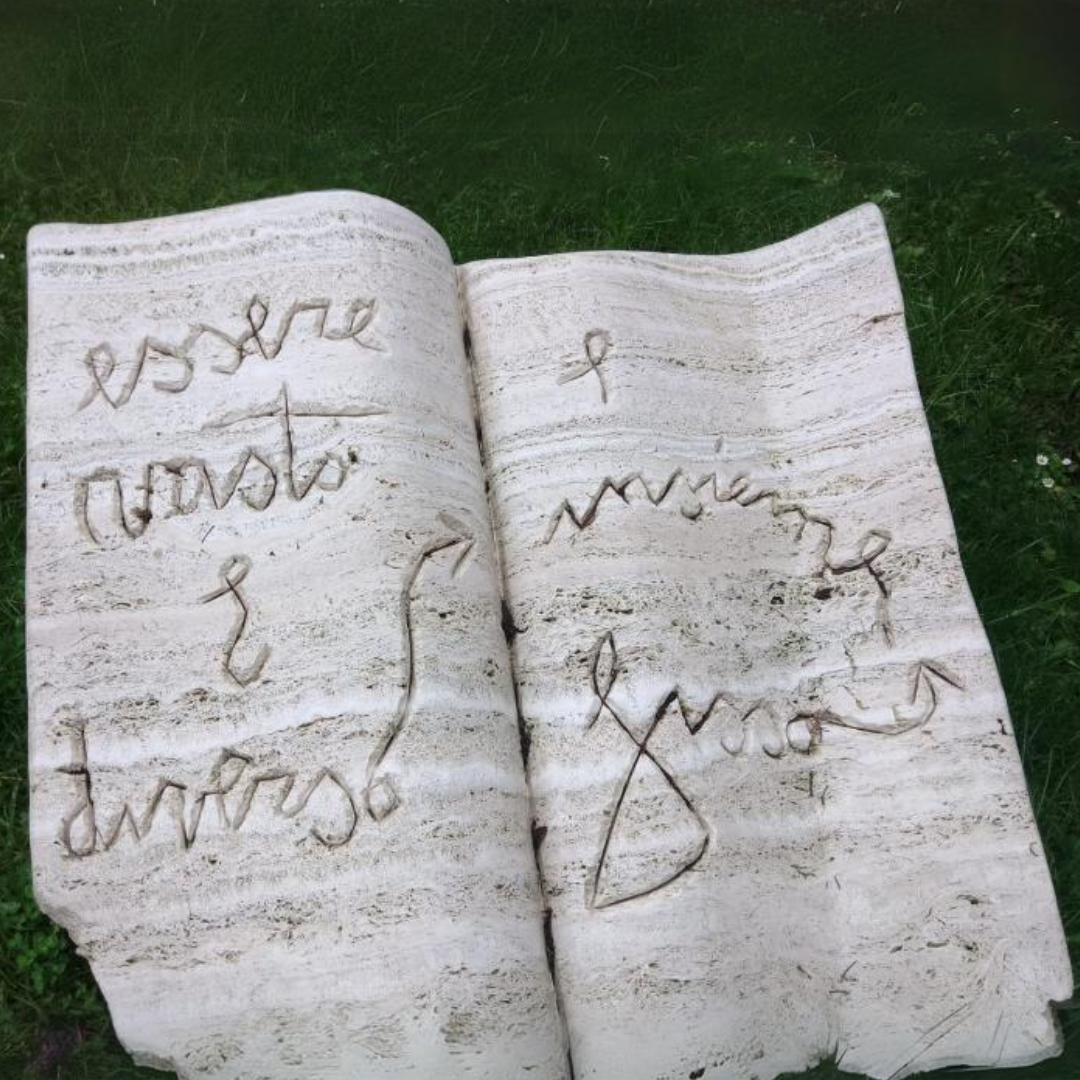Persi nei loro sogni di palingenesi e amore universale, non furono, però, forse mai, in grado di valutare fino in fondo le conseguenze delle loro azioni e ne pagarono tragicamente le conseguenze. Lui, di famiglia aristocratica, poeta sublime, capace di credere che bastasse volere il bene perché esso si realizzasse, come avrebbe scritto Mary dopo la sua morte, soffriva di ogni ingiustizia e miseria altrui come se fossero state inferte a lui stesso e si prodigava in ogni modo, con gli scritti e i mezzi finanziari di cui disponeva, per alleviarle.
Lei (dobbiamo accennare alle sue vicende familiari che sono la chiave di lettura della sua personalità ma anche di quanti si mossero intorno a lei) era figlia della grande femminista Mary Wollstonecraft, scrittrice e giornalista, che si era recata a Parigi per seguire in prima persona la rivoluzione francese e aveva dedicato a Taillerand la sua Rivendicazione dei diritti della donna divenuta ben presto famosa in tutta Europa. E che, di fronte al fallimento dei suoi sogni nelle stragi del Terrore e, sul piano personale, all’abbandono da parte del padre di Fanny, nata dalla loro relazione in Francia, aveva tentato il suicidio come non pochi suoi contemporanei. Sopravvissuta a ben due tentativi, aveva sposato il filosofo anarchico e pacifista William Godwin, autore di moltissime opere tra cui il celebre romanzo Caleb Williams e il saggio Political Justice, a sua volta implicato, come filo-giacobino, nei processi del 1794 contro i nemici della patria, e costretto, a causa dei suoi trascorsi politici, a sudarsi il pane con difficoltà per tutta la vita. Ma proprio quando la sua vita e la sua attività sembravano entrare in una nuova fase apportatrice di gioie e di qualche speranza, Mary Wollstonecraft era morta, a 37 anni, nel mettere al mondo la futura Mary Shelley.
I suoi due primi cognomi, Wollstonecraft e Godwin, Mary se li era dunque trovati addosso come una condanna nell’Inghilterra in guerra contro la Francia. Eppure li aveva assunti come una bandiera. Sua madre sarebbe stata per lei un modello; per tutta la vita avrebbe studiato le sue opere cercando di attuarne gli ideali; per il padre avrebbe nutrito un amore forte, forse più di qualunque altro, come lei stessa scrisse nel libro autobiografico Mathilda. Mary aveva sentito i suoi famosi genitori, tanto esaltati quanto disprezzati nel mondo diviso di allora, come una gloria, e aveva amato e voluto come suo compagno di vita Percy Shelley che si considerava loro allievo morale e che le aveva dichiarato il suo amore sulla tomba di Mary Wollstonecraft dove lei si recava ogni giorno a leggerne i libri.
Di fronte al veto, per loro giovani incomprensibile, di Godwin, che li aveva cacciati (aveva scritto a Shelley “non si abbandona una moglie onorata e non si rovina la giovinezza di mia figlia”) e all’indignazione di tutta Londra che non ingiustamente insorgeva a difendere la prima moglie di Shelley, Harriet Westbrook, già madre di una bimba e in attesa di un secondo figlio, i due fuggirono da Londra, ratificando il loro destino di paria. Per otto anni sarebbero fuggiti attraverso l’Europa e soprattutto l’Italia, il Paradiso degli esuli, come diceva Shelley, cercando e incontrando altri esuli come loro. E tra questi, al primo posto, Lord Byron, al quale li legò quasi un vincolo di sangue, più ancora che un’amicizia, avendo avuto il Lord una figlia da Claire, Allegra, che volle con una determinazione incoercibile, sottrarre alla madre a causa di una sua presunta indegnità e che relegò poi in un convento di suore a Bagnacavallo, nel Ravennate, dove la bimba morì di tifo a 6 anni.
La loro vita fu in realtà un susseguirsi di lutti e di tragedie, di suicidi nell’ambito familiare e di morti di figli bambini., e si concluse con una sciagura per lui e con una lunga segregazione per lei a Londra, dove, nella solitudine e nell’emarginazione, chiusa in una stanza per ben 30 anni, sarebbe vissuta di scrittura, l’unico suo mezzo di sostentamento ma anche suo universo di vita, pieno di ricordi laceranti e di avventure di conoscenza, lungo viaggio di meditazione e di purificazione, cammino lento dalla disperazione alla gioia e anche all’estasi. Ci hanno lasciato entrambi opere difficili, piene d’amore per l’umanità e per l’universo. Di lui ricordiamo, opere in versi o in prosa in cui la poesia non è mai disgiunta dall’impegno civile e sociale, anzi diventa il tramite per la realizzazione, almeno nel mondo del sogno e della parola, dell’utopia. Dal Prometeo liberato, opera in versi ancora oggi rappresentata in teatro, canto sulla reale possibilità che l’amore e la fratellanza si realizzino nell’Universo per volontà degli uomini, a Il Trionfo della vita scritto a San Terenzo, oltre a numerose tragedie, traduzioni, poemi, scritti a carattere filosofico e invettive contro la guerra e la violenza degli stati. Di lei ricordiamo soprattutto lo straordinario romanzo che compose quando aveva appena 18anni, il Frankenstein di cui tanto si parla oggi. Sì, fu lei che lo scrisse anche se si continua a dimenticarlo e subito, quando uscì, divenuto immediatamente celebre, fu attribuito a suo marito. Cose che continuano a capitare alle donne, anche oggi, come si sa…
Eppure Shelley non avrebbe voluto quell’attribuzione: era anzi un entusiasta sostenitore dell’opera di Mary e ben consapevole della sua grandezza, anche se presentiva che sarebbe dovuto passare molto molto tempo prima che venisse riconosciuta. E questa è un’altra caratteristica di questo gruppo di artisti: avevano tutti doti profetiche. Ciascuno di loro, Shelley, Mary, Claire, Byron, ebbe sempre chiara la percezione della propria morte o di quelli che amavano, e anche nelle loro opere toccarono temi che andavano ben oltre la loro breve vicenda terrena. Quella che vide oltre il suo tempo in modo ancora oggi impressionante, è Mary Shelley. Il Frankenstein ha saputo esprimere il nostro terrore di fronte agli orrori che la scienza può produrre, di più, di fronte alle stragi che può pianificare, meglio di ogni altra profezia. E vale la pena di sottolineare che Mary ideò il Frankenstein a Villa Diodati, in una gara letteraria voluta da Lord Byron cui parteciparono anche Shelley e William Polidori (anch’egli morirà suicida all’età di 25 anni per mezzo del cianuro) il quale scrisse, in quell’occasione, Il Vampiro, destinato, come il Frankenstein di Mary, a diventare l’altro mito nero del nostro tempo. Un mito pauroso, pieno del terrore del male che torna invincibile come l’antico ordine monarchico nell’Europa rivoluzionaria e napoleonica sconfitta, tanto astratto e cosmico, quanto il mito di Mary è terreno e umano.
Il Frankenstein è infatti la storia della scelta errata di uno scienziato che vorrebbe sì fare il bene dell’umanità e sconfiggere la morte, ma si affida poi, per attuare il suo sogno, a una scienza che non cerca l’elevazione morale di chi la pratica, come quella degli antichi alchimisti che si sottoponevano a una disciplina ascetica durissima. Quindi, assemblando pezzi di cadaveri diversi e con l’aiuto di una macchina mossa da correnti elettriche (era il momento di quelle scoperte!) a infondere di nuovo la vita in un mostruoso corpo morto. Ma di fronte alla richiesta di amore della terribile creatura che gli si para davanti, commette l’infamia di fuggire. Abbandonato così all’orrore di quanti lo vedranno, cacciato da ogni luogo e braccato, il mostro che è tale all’aspetto, ma non di animo, si trasforma in un essere cattivo e perverso come il suo creatore. Il romanzo è la storia della scienza che non vuole far progredire l’umanità nel rispetto della natura e degli uomini, ma che afferma il proprio diritto a violare ogni ordine naturale e morale. E pertanto riduce a orrore ciò che potrebbe essere evoluzione e progresso, e induce gli uomini, che sono naturalmente buoni (questo continuò sempre a pensare la illuminista e romantica Mary) a diventare cattivi e assassini. Tanto che, nella tradizione orale, lo scienziato e il mostro sono diventati tutt’uno, e il nome Frankenstein viene attribuito a entrambi. Le innumerevoli versioni cinematografiche, e il continuo uso che si fa del nome di Frankenstein nei media testimoniano quanto l’intuizione di Mary sia attuale, e investa nostre paure tutt’altro che infondate di fronte a quanto la scienza contemporanea, da Hiroshima in poi, ha saputo fare.
L’attualità del mito del vampiro è altrettanto evidente a tutti data il suo perpetuo rinnovarsi, da Bram Socker in poi fino alla saga di Twilight. Rimane il fatto straordinario che questi due miti, diventati patrimonio di tutti, mentre i nomi dei due giovani autori si perdevano nelle nebbie del passato, sono scaturiti da quel gruppo di intellettuali e artisti che Mary chiamerà Gli Eletti, tra cui lei spiccava per doti allora ben evidenti a tutti ma poi misconosciute fino, si può dire, a oggi.
La gente di San Terenzo non sapeva nulla del valore e del significato delle opere di quegli stranieri così diversi da loro, di quei foresti, come vengono ancora oggi chiamati quanti vengono da altri luoghi: vedeva che sapevano leggere e scrivere e che erano davvero ricchi: ma mangiavano peggio e meno di loro, poveri pescatori analfabeti. Bevevano una bevanda scura che chiamavano tè, si nutrivano quasi solo di pane e frutta secca e in casa non avevano pentole a sufficienza. Eppure arrivava da loro gente in continuazione, che sbarcava e si fermava anche a dormire.
Il paese era, si direbbe, in subbuglio. E poi era Shelley, il marito, che si occupava di trovare aiuto domestico per la casa; la moglie era sempre sdraiata da qualche parte a leggere o a scrivere! Lui, che era un poeta (ma che cosa mai avrà voluto dire quella parola?) se la faceva con la moglie dell’amico e anche con la cognata quando arrivava dai suoi viaggi. E poi, e questo era il colmo, la moglie, Mary, quando nessuno la vedeva, usciva da sola a camminare e a piangere per i sentieri più solitari, malata com’era.
L’incomprensione si mescolava a derisione e talvolta a disprezzo: lui, il poeta, che era sempre in acqua, più nudo che vestito, non sapeva nuotare. Ma non capiva che il mare uccide, anche i giovani, anche i belli, anche i poeti?
Era stato Shelley, come si è detto, a scegliere casa Magni come abitazione. Era arrivato nel Golfo della Spezia a cercare, ancora una volta, un’abitazione, insieme a Edward Williams, nel febbraio del 1822. Era di nuovo in fuga, anche da Pisa dove, per sua stessa ammissione, era stato bene come in nessun altro posto: era attanagliato da ossessioni e rimorsi che si tramutavano in dolori fisici e in un’irrequietezza inarrestabile. L’ossessione per il suicidio di Harriet (la prima moglie, lasciata per fuggire con Mary) e per quello di Fanny (la sorella di Mary) che gli veniva, non si sa quanto giustamente, imputato, e per la morte dei figli, travolti dalle sue fughe inarrestabili, lo tormentava. Solo il laudano, preso in grande quantità, fino a causargli allucinazioni, o il perdersi nell’acqua, sui laghi o in mare, su imbarcazioni che lo trascinavano lontano, o nuovi amori, sempre cercati e sommati a quello immortale per Mary, gli davano sollievo. Anche se per poco.
Era gentile di aspetto, e bellissimo, il baronetto Percy B. Shelley, quasi un angelo, come lo hanno immortalato i busti marmorei di Moses Ezekiel, di Urbano Lucchesi e di William Wetmore Story. I suoi capelli biondi erano ormai ingrigiti e i denti cominciavano a guastarsi, ma la sua voce squillante era sempre sopra tono, un po’ stonata anche, come quando era ragazzo Allora non era famoso, come poeta, se non negli ambienti letterari: ovunque appariva, invece, come un uomo apportatore di scandali e di offese alla morale. “E’ lei quel dannato ateo di Shelley, lo spergiuro? Ecco, questo è per lei!” Gli avrebbe urlato un militare nell’ufficio postale di Roma colpendolo con un pugno in pieno viso e facendolo svenire…
Era stato lui che, affacciandosi per primo alla Bellavista, aveva sentito il cuore fermarsi per lo stupore di fronte alla visione del mare su cui le tre isole, la Palmaria, il Tino e il Tinetto, si protendevano come immensi cetacei persi nella luce rosata, mentre all’orizzonte, sulla linea curva dell’infinito, apparivano altre ombre. Altre isole, la Gorgona, la Capraia e la Corsica, ancora oggi dette “Isole dei Beati” perché compaiono solo quando la tramontana spazza via ogni nebbia e da sempre sono state credute la dimora dei trapassati.
Era stato lui che aveva visto per primo, da Lerici, la bianca villa che sorgeva sull’acqua luccicante al di là del mare pieno di mille riverberi e profumi e deciso che sarebbero venuti tutti a stare lì, immediatamente, anche se la casa era vuota e i mobili non potevano essere trasportati che via mare e anche se Mary, era ben noto a tutti, non voleva lasciare Pisa.
Avrebbe poi scritto Mary: “Una sciocchezza come non trovar casa non poteva fermare un uomo come Shelley … quell’unica che era stata trovata doveva servire per tutti… lasciammo Pisa il 26 aprile”.
Pisa era stata per Mary una convalescenza. Vi era arrivata arsa dalla polvere dei viaggi, con l’ultimo e unico figlio rimastole, Percy Florence, temendo che anche l’aria potesse essergli nemica. Aveva paura di tutto, ormai, dopo otto anni di tempeste e di fughe per l’Europa e l’Italia.
Shelley era stato un fulmine nella sua vita di ragazza; l’aveva trascinata via dalla casa dell’infanzia e dal padre amatissimo che non l’avrebbe perdonata mai. Era stato lo stacco, la fuga contro tutti, e poi lutti, passioni, per l’Arte, la Poesia, la Rivoluzione: estasi o disperazione. Serenità mai. In otto anni, qualche mese soltanto, a Marlow, in Inghilterra, con i bimbi piccoli, prima che arrivassero il suicidio di Hariet e poi quello di Fanny, e poi, in Italia, la morte dei figli Clara e William, le lotte disperate per ridare Allegra a sua madre, lo scandalo napoletano di M. Adelaide, la bimba che voci ostili attribuivano a Claire e Shelley, anche lei morta a pochi mesi.
Mary era una donna di ventiquattro anni, provata fisicamente e psicologicamente: aveva capelli castani e un ovale morbido. Con la testa divisa tra le trame dei romanzi e dei racconti che scriveva ininterrottamente e gli impegni domestici. Ma tanto Shelley era loquace, tanto lei era silenziosa. Ai tanti lutti che l’avevano travolta aveva reagito, a differenza di lui che aveva sempre dolori per tutto il corpo, con una depressione profonda, che le toglieva parola e movimento.
Era famosa per aver scritto il romanzo Frankenstein, ma non lo sapeva. Lo avrebbe scoperto quando, tornata a Londra, lo trovò rappresentato a teatro. Ma, per un paradosso della storia, lei famosa in vita, sarebbe stata poi presto dimenticata, adombrata dalla fama di Shelley che lei stessa aveva contribuito a creare.
Era incinta. Ma non provava alcuna gioia nell’aspettare il ripetersi del miracolo della nascita, nel darsi totalmente a un figlio per vederlo poi finire nella morte.
Era malata fisicamente e psichicamente, come lei stessa ammetteva, e dominata da presentimenti di morte.
Ormai non soffriva neppure più per gli amori sempre rinnovantisi di Shelley: gli ultimi a Pisa, per Teresa Viviani, che aveva ingenuamente creduto di dover salvare da una monacazione forzata e che si era invece presa gioco di lui, convolando poi a nozze; quello più recente per Jane Williams e quello antico per Claire Clairmont, che si riproponeva sempre quando lei tornava dai suoi viaggi, riuscivano persino a farla sorridere. Lei trovava pace e gioia solo nel suo regno di visioni e sogni, il mondo della fantasia in cui fuggiva, sbarrandosi nello studio, e da cui traeva le storie di amori, magie e intrighi per i suoi romanzi. Aveva appena scritto la vita di Castruccio Castracani (o Valperga) e dato corpo al suo sogno di una storia che avrebbe potuto essere diversa, costruita da quelli che cercavano la pace.
Quanto Shelley, e forse ancora più di lui, fu presa dalla malia del luogo. Ma capì subito, con una violenza che si ripercuoteva sul suo fisico malato, che quella bellezza così assoluta, quasi insostenibile per i suoi occhi che cercavano l’ombra, li avrebbe immessi in una dimensione oltre l’umano. Non c’era posto per il dolore in quel luogo che sembrava l’alba di un mondo, pieno di una luce che scolorava dall’azzurro e rosa dell’alba all’accecante biancore del giorno e non conosceva soste, come il canto dei grilli, e quello delle cicale o i mille profumi intensi che arrivavano a folate. Anche la morte, lì, sembrava esistere solo per la felicità.
La prese il presentimento di un evento tremendo, che l’avrebbe annientata.
Il ventre le si contraeva e lei doveva stare sdraiata: nelle lunghe ore di solitudine con il viso contro la parete, che riverberava i colori del mare e del cielo, sentiva che ogni sua fibra era all’erta, come in un’attesa che la paralizzava.
“… Il luogo era troppo bello e non sembrava di questa terra: la lontananza di ogni traccia di civiltà, il mare ai nostri piedi, il suo incessante mormorio e il suo mugghio nelle nostre orecchie – tutto invitava la mente a meditare su strani pensieri e, sollevandola dalla quotidianità, l’induceva a familiarizzare con l’irreale”.
Così avrebbe ricordato quei luoghi nella Londra che non le avrebbe mai perdonato il suo passato.
Un’atmosfera piena di prodigi, come un incantesimo, li carpiva, il riverbero azzurro del cielo e del mare li stordiva: avvenivano fatti straordinari, visioni che non sapevano se fossero incubi del sonno o allucinazioni da laudano o manifestazioni di una realtà, di più, di un disegno, ultrasensibili.
Le sembrava che fossero tutti prigionieri del destino tragico che si sarebbe compiuto proprio lì, segnando la fine della vita di Shelley e dando una svolta definitiva alla sua.
L’incantesimo era nei luoghi, “la cui bellezza mi faceva tremare e piangere”, avrebbe scritto, prima ancora che nella loro vita, nel Golfo, nella piccola baia di San Terenzo, nella casa.
La loro vicenda, qui, nel Golfo dei Poeti, si è svolta nel segno della tragedia: e noi non possiamo modificarla. Ci tocca di raccontarla così, anche se vorremmo poter trovare, in quelle vite, momenti anche un po’ banali, ma almeno un po’ più sereni, un po’ più gioiosi…
La barca, la Don Juan, ribattezzata poi Ariel, costruita a Genova insieme al Bolivar di Byron (che aveva tre alberi e ben quattro cannoni), arrivò il 12 maggio.
Si erano schierati tutti sulla spiaggia e le davano il benvenuto battendo le mani.
Due uomini si sporgevano tra le vele e facevano volute giocando con il vento. “È una barca splendida e supera a tal punto le mie aspettative e quelle di Williams che ci siamo persuasi che ci abbiate mandato il Bolivar per sbaglio” scriveva Shelley al capitano Roberts. “Supera le imbarcazioni piccole come una cometa potrebbe superare i pianeti più lenti del cielo”.
Avrebbe raccontato Mary, venti anni dopo:
“Fu così che imprevidenti mortali diedero il benvenuto alla Morte, che aveva nascosto le sue sinistre certezze sotto una maschera attraente! Da quel momento il tempo dedicato agli amici lo si passava in mare; il tempo si fece bello, e spesso tutta la compagnia trascorreva le sere sull’acqua, quando il vento prometteva una piacevole navigazione. Shelley e Williams facevano viaggi più lunghi: più di una volta si spinsero fino a Massa. Avevano ingaggiato uno dei marinai che ci avevano portato la barca, un ragazzo di nome Charles Vivian: e non avevano la minima percezione del pericolo. Quando il tempo era sfavorevole si dedicavano a sistemare meglio le attrezzature, e a costruire una barchetta di tela e giunchi, la più leggera possibile, da tenere a bordo dell’altra in modo da poter sbarcare in acque troppo basse per il vascello più grande. Quando Shelley era a bordo teneva con sé le sue carte, e gran parte del Triumph of Life fu scritta mentre navigava”.
Da quel momento la spiaggia intorno a Villa Magni sembrò un porto: tutto il giorno era un continuo andare e venire dalla spiaggia alla barca, dal mare a casa; dove tutto era bagnato e pieno di sabbia.
Il 13 giugno apparve nelle acque tranquille della baia, come una nave pirata, la Bolivar di Lord Byron, guidata dal Capitano Roberts, che, su ordine del Lord, sparò ben sei colpi di cannone per salutare gli amici, seminando il panico tra la povera gente del borgo.
Con grande disapprovazione degli abitanti, i bimbi, e spesso anche Shelley e Williams, si aggiravano nudi. Il capitano Roberts impartiva lezioni di vela.
Mary usciva per passeggiare a piedi tra i vigneti dietro alla casa o su per il promontorio di Falconara: quando accettava di uscire in barca si inginocchiava e appoggiava la testa sulle ginocchia di Shelley, secondo un suo antico costume, e si lasciava andare al vento.
I dolori al ventre si facevano sempre più forti: Shelley cercava di compiacerla, ne sentiva il male fino in fondo. Lui, però, di fronte a quel mare si sentiva felice.
“La mattina me ne sto seduto in casa e la sera usciamo un po’ con la barca – scriveva a Claire - Ho ripreso a scrivere. Leggo, e per la prima volta in dieci anni, mi godo qualcosa che assomiglia alla salute. Trovo comunque che devo evitare di pensare e di emozionarmi, o il dolore ritorna al vecchio nido”.
Ci furono anche episodi che, ripensati anni dopo, avrebbero fatto sorridere Mary, mentre allora la turbavano soltanto.
Avrebbe ricordato con tenerezza Shelley sulla porta del salotto di Villa Magni mentre lei e alcune signore prendevano il tè: completamente nudo. Veniva dal mare, era bagnato e aveva i piedi ricoperti di sabbia. Le signore erano sconvolte: non sapevano che comportamento tenere e roteavano gli occhi tutt’intorno. Lei avrebbe voluto che il pavimento della stanza si aprisse in una voragine e la inghiottisse: ipnotizzata guardava Shelley, aspettava solo che lui dicesse qualcosa e scomparisse. Ma lui continuava ad avanzare, silenzioso, gentile, con il passo di chi dice: “Ecco, ora mene vado di là, devo solo attraversare la stanza, ma cercherò di non disturbarvi”.
E con una grazia lenta in uno spazio di tempo incalcolabilmente eterno, durante il quale tutte le sue belle nudità potevano con cura essere osservate e valutate, percorreva ben tre lati della saletta e poi scompariva attraverso una porta lasciando tracce di piedi bagnati e sabbia sul pavimento.
E la sera: “Ma come Mary? Ero nudo? Ero nudo davvero, Mary? Ma si vedeva proprio?” Shelley Shelley!
Certe sere lei entrava nel suo studio, e lo trovava che leggeva, vicino al camino, con la colazione intatta sulla scrivania. Credeva che fosse uscito. La casa sembrava vuota. “Sei qui, Shelley? E non hai mangiato? Allora sei digiuno da ieri sera!”
“Davvero, Mary, ne sei sicura?” Rispondeva proprio così.
Una volta suo cugino Medwin li aveva invitati a cena e lui aveva risposto (bisognava vedere il viso di Medwin): “Non so se possiamo venire perché forse abbiamo già cenato.” E poi chiamandola a gran voce: “Abbiamo già cenato stasera, Mary?”
Era sempre così generoso.
Mary si sarebbe sempre commossa ripensando a lui quando tornava dalle varie barche con una enorme borsa piena di monete, la sua rendita, e la rovesciava sul tavolo e ne faceva dei mucchi: questo per Godwin, questo per Mary, questo per… questo per…e per sé non teneva nulla. Solo il denaro per la sua barca e i suoi libri.
Era innamorato di nuovo e dedicava a Jane versi pieni di oblio e di dolcezza. Scriveva all’amico John Gisborne:
“…e navighiamo in questa baia deliziosa nel vento della sera, sotto alla luna estiva, finché la terra sembra un altro mondo, Jane porta la chitarra e se passato e futuro potessero essere dimenticati, il presente mi renderebbe felice al punto che, come Faust, potrei dire al momento che passa Rimani oh tu che sei così bello”.
Leigh Hunt, il grande amico editore fatto venire apposta da Londra per editare “The Liberal”, stava per arrivare a Genova: amore, amicizia, mare, cielo, per qualche attimo Shelley riusciva ad essere felice:
“il passato e il futuro
erano dimenticati, come
non fossero mai stati o dovessero essere”
scriveva nei Versi scritti nel Golfo di Lerici, ma sconsolatamente concludeva:
“Ma subito, appena il mio angelo
custode scomparve, ritornava il demone
a riprendersi il trono del mio cuore fragile”.
Il 16 giugno tutto precipitò.
Mary ebbe un’emorragia che sembrò toglierle la vita: Shelley riuscì a salvarla, immergendola nel ghiaccio dentro alla vasca da bagno, in attesa che arrivasse il medico troppo lontano; ma la partecipazione all’aborto e la sensazione di perdere anche lei gli avevano dato un ennesimo colpo insopportabile.
Shelley voleva partire per Livorno per raggiungere Leigh Hunt, a Pisa: doveva sistemarlo con la famiglia presso Byron e poi avrebbero lavorato al loro sogno letterario-politico, il “The Liberal”.
Mary lo supplicava, perdeva sangue quando lui parlava di partire. Ma il primo luglio non riuscì più a trattenerlo: Shelley partì con Edward e Charles Vivian.
Nella lettera che Mary scrisse a Maria Gisborne il 15 agosto 1822 è ricostruita l’ultima tragica vicenda della loro vita: qui diremo soltanto che l’8 luglio, sulla rotta di ritorno da Livorno, a circa dieci miglia da Viareggio, l’Ariel affondò travolto da tempeste e trombe d’aria. E che solo dopo dieci giorni dopo il mare buttò sul litorale i tre corpi, Shelley sulla spiaggia di Viareggio, Williams a tre miglia di distanza, Charles Vivian a Massa.
Mary chiese che il rogo avvenisse con il rito che Virgilio descrive nell’Eneide, cioè con spargimento di olio e vino aromatico e incenso sui cadaveri.
Una leggenda racconta che Trelawny riuscì a strappare dalle fiamme il cuore di Shelley che non bruciava e lo portò in una scatola di legno a Mary che lo tenne con sé, per sempre.
Una piccola urna contenente frammenti delle ossa di Shelley è conservata alla Memorial House dedicata a Byron, Keats e Shelley a Roma, in Piazza di Spagna 25 (Il museo è davvero affascinante, retto da persone gentilissime e molto preparate, e merita di essere visitato, anche perché riguarda tutti i personaggi del circolo Shelley e ha dedicato, negli ultimi anni, molta attenzione anche alle opere di Mary).
Scompariva così il poeta sublime e la sua vita dovette apparire a Mary e, ancora a noi appare, come il baluginio di un astro travolgente allontanatosi per orbite inimmaginabili.
“Comincia il mio diario di dolore – scriveva Mary a San Terenzo – devo tornare in Inghilterra dove mi aspettano umiliazioni e orrori, devo vivere per mio figlio”.
Quando, nella sua solitudine, Mary ripensava a quanti aveva amato e perduto, certamente doveva sembrarle, a tratti, di riuscire a leggere nel destino umano suo e di Shelley i segni di un ordito intessuto da mani non umane. Non poteva decifrarlo, ma quel disegno, che la ossessionava con il suo carico di dolore, le appariva sempre più connesso con questi luoghi meravigliosi e lontani, e poi con il silenzio della sua stanza che le rimandava i suoni della loro passione e l’eco dei sogni, come se fossero sempre vivi.
Le sembrava che, quella morte prematura e tragica, all’età di ventotto anni, che tutti avevano paventato e che lui aveva presentito e descritto nelle sue opere e poi cercato in quelli anni di esilio, quasi espiazione, quasi sacrificio, quasi suicidio, avesse permesso ai suoi sforzi per la libertà e la giustizia di realizzarsi.
Scriveva: “Lo Spirito del Bene che sa giudicare il cuore, non lo respinse mai, […] La sua influenza sull’umanità, sebbene lenta a svilupparsi, sta aumentando velocemente, e nei miglioramenti che hanno avuto luogo nella situazione politica del nostro paese, possiamo in parte riconoscere il risultato delle sue ardue lotte”.